 olto è stato scritto nell’ultimo secolo circa l’origine e le motivazioni che spinsero Bach a produrre i sedici arrangiamenti per tastiera (BWV 972-987), che, non va dimenticato, sono in stretta relazione con i cinque analoghi fatti specificatamente per l’organo (BWV 592-596). In passato, già nel saggio di Forkel del 1802, fu ipotizzato che tale assidua attività di trascrizione doveva essere necessariamente legata all’auto-formazione del musicista tedesco nel campo del concerto vivaldiano. Questa spiegazione è stata accantonata come poco plausibile per vari motivi, da H.-J. Schulze nel 1972 ed in altri saggi successivi; il motivo più importante sembra essere legato all’influenza della figura del principe Johann Ernst (1696-1715) sull’attività compositiva di Johann Sebastian, a quel tempo impiegato alla corte di Weimar. Il principe di Sassonia-Weimar, ancora molto giovane, fu inviato a completare gli studi universitari ad Utrecht, dal febbraio 1711 al luglio del 1713. In quel periodo, Johann Ernst visitò Amsterdam e Düsseldorf dove probabilmente alimentò le proprie conoscenze musicali, poi perfezionatesi ulteriormente al suo ritorno sotto la guida dell’organista di Weimar, J. G. Walther, lontano cugino di Bach nonché amico. Per questo motivo, il periodo 1713-1714 è quello comunemente associato alla data di composizione di tutti questi lavori, visto che il principe (molto malato) lasciò Weimar nel luglio 1714 per non farvi mai più ritorno. L’idea suggerita da Schulze è che questi lavori furono quindi commissionati a Bach dallo stesso principe, il quale poteva così assecondare il grande amore per questa forma così innovativa che era il concerto italiano, un genere probabilmente già ben noto a Johann Sebastian da almeno cinque anni. Quello che sappiamo per certo è che, negli anni successivi, soprattutto a Lipsia, tutte queste trascrizioni per tastiera rimasero molto in voga ed utilizzate dal compositore ed il suo entourage. Dei sedici concerti, tre (BWV 977, 983, 986) non sono stati ancora identificati tra le composizioni note di altri musicisti, mentre la maggior degli altri provengono tutti da Op.3 e Op.4 di Antonio Vivaldi e dai 6 concerti per violino dello stesso Johann Ernst Prinz von Sachsen-Weimar. A questi si aggiungono un concerto da Telemann (BWV 985), due concerti dai fratelli Marcello (BWV 974, 981) ed infine il concerto in si minore (BWV 979) che si considera tradizionalmente preso da un concerto in re minore di Torelli, ma che invece secondo alcuni sarebbe ancora un concerto giovanile (oggi perduto) di Vivaldi, identificato nell’appendice del catalogo con RV Anh 10.
olto è stato scritto nell’ultimo secolo circa l’origine e le motivazioni che spinsero Bach a produrre i sedici arrangiamenti per tastiera (BWV 972-987), che, non va dimenticato, sono in stretta relazione con i cinque analoghi fatti specificatamente per l’organo (BWV 592-596). In passato, già nel saggio di Forkel del 1802, fu ipotizzato che tale assidua attività di trascrizione doveva essere necessariamente legata all’auto-formazione del musicista tedesco nel campo del concerto vivaldiano. Questa spiegazione è stata accantonata come poco plausibile per vari motivi, da H.-J. Schulze nel 1972 ed in altri saggi successivi; il motivo più importante sembra essere legato all’influenza della figura del principe Johann Ernst (1696-1715) sull’attività compositiva di Johann Sebastian, a quel tempo impiegato alla corte di Weimar. Il principe di Sassonia-Weimar, ancora molto giovane, fu inviato a completare gli studi universitari ad Utrecht, dal febbraio 1711 al luglio del 1713. In quel periodo, Johann Ernst visitò Amsterdam e Düsseldorf dove probabilmente alimentò le proprie conoscenze musicali, poi perfezionatesi ulteriormente al suo ritorno sotto la guida dell’organista di Weimar, J. G. Walther, lontano cugino di Bach nonché amico. Per questo motivo, il periodo 1713-1714 è quello comunemente associato alla data di composizione di tutti questi lavori, visto che il principe (molto malato) lasciò Weimar nel luglio 1714 per non farvi mai più ritorno. L’idea suggerita da Schulze è che questi lavori furono quindi commissionati a Bach dallo stesso principe, il quale poteva così assecondare il grande amore per questa forma così innovativa che era il concerto italiano, un genere probabilmente già ben noto a Johann Sebastian da almeno cinque anni. Quello che sappiamo per certo è che, negli anni successivi, soprattutto a Lipsia, tutte queste trascrizioni per tastiera rimasero molto in voga ed utilizzate dal compositore ed il suo entourage. Dei sedici concerti, tre (BWV 977, 983, 986) non sono stati ancora identificati tra le composizioni note di altri musicisti, mentre la maggior degli altri provengono tutti da Op.3 e Op.4 di Antonio Vivaldi e dai 6 concerti per violino dello stesso Johann Ernst Prinz von Sachsen-Weimar. A questi si aggiungono un concerto da Telemann (BWV 985), due concerti dai fratelli Marcello (BWV 974, 981) ed infine il concerto in si minore (BWV 979) che si considera tradizionalmente preso da un concerto in re minore di Torelli, ma che invece secondo alcuni sarebbe ancora un concerto giovanile (oggi perduto) di Vivaldi, identificato nell’appendice del catalogo con RV Anh 10.
La Suite in sol minore di Wilhelm Friedemann Bach sembra essere l’unica composizione del genere che ci è pervenuta dal primogenito di Sebastian Bach. Non sappiamo se siano stati fatti dei seri tentativi di datazione della composizione, operazione non semplice ed ulteriormente complicata dal fatto che molta musica di Friedemann, più di quella del fratello minore Philipp Emanuel, presenta elementi stilistici apparentemente ricorrenti negli anni. Tra questi, ci sono anche forti legami con alcuni procedimenti compositivi paterni, come nel caso in oggetto che viene spesso accostato alla Partita III (BWV 827), per la presenza dei ritmi puntati nell’Allemande e Courante.
Tutto il resto della pagina è dedicato alla seconda parte del Quaderno per Anna Magdalena Bach che Johann Sebastian compilò attorno al 1725, con aggiunte successive. L’importanza di questa raccolta è data dalla presenza di versioni preliminari di due delle partite (BWV 827 e 830) e di due delle suite francesi (BWV 812 e 813), che qui non vengono registrate. Sappiamo che le 6 Partite (che abbiamo già registrato qui) verranno pubblicate nella loro forma definitiva da Bach a partire dal 1726, anno dopo anno fino al 1730 e poi ripubblicate tutte insieme nel 1731. La presenza delle due suite francesi (che abbiamo già registrato qui) nel quaderno del 1725 è uno dei motivi per cui si tende a datare queste composizioni vari anni dopo le analoghe suite inglesi. La gran parte di ciò che resta del quaderno è stata qui registrata dal De Luca, escludendo naturalmente le arie vocali, alcuni preludi corali e pochi altri brani singoli, come il Rondeau BWV Anh 183 che è in realtà un brano di François Couperin (noto come Les Bergeries dal VI Ordre) ed il Menuet fait par Mons. Böhm, non incluso nel catalogo bachiano. Tra i 18 brani qui registrati, i minuetti in sol maggiore e sol minore (BWV Anh 114-115) risultano ben noti agli studenti principianti di pianoforte e sono stati attribuiti ormai da tempo alla mano di Christian Pezold. I pezzi di Carl Philipp Emanuel sembrano invece essere composizioni successive, 1730/31, aggiunte successivamente al quaderno. La Musette in re maggiore (BWV Anh 126) e la Polonaise in sol maggiore (BWV Anh 130) sono state attribuite con assoluta incertezza a Georg Philipp Telemann e Johann Adolf Hasse. Tutti i restanti brani, di autore anonimo, sono probabilmente basati su melodie popolari che lo stesso Bach potrebbe aver arrangiato in forma elementare, forse con la collaborazione di Wilhelm Friedemann e la stessa Anna Magdalena.
saladelcembalo.org
6 giugno 2017
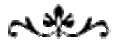
FERNANDO DE LUCA
harpsichord

Issue 2017-15
Recorded in Venice
August 2014 / April 2016 / August 2016
German harpsichord after Christian Vater (1738), built by F. P. Ciocca (2007); Pitch A=415Hz

F. De Luca (photo 2016 by M. Toso)